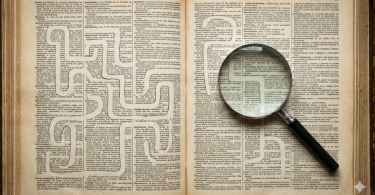Questo episodio della rubrica Dopo i titoli di coda è tratto dal Sussidio per il Giubileo 2025. Lo trovate qui.
Tutto l’amore che serve
“Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli?”(1Sam 1,8). Sono le parole di Elkanà per la moglie Anna: con orante pazienza questa donna dell’Antico Testamento metterà al mondo il profeta Samuele. Di un Elkanà non c’è traccia nella vita di Mona, protagonista di Tutto l’amore che serve. Non che Elkanà fosse una garanzia visto che aveva due mogli alle quali dedicarsi e la seconda, Peninnà, era tutt’altro che morbida nei confronti del grembo sterile di Anna.
Eppure, nella casa di Mona e Joël, alle porte di Parigi, un Elkanà sarebbe stato quel provvidenziale terzo incomodo capace di spezzare la simbiotica relazione tra madre e figlio, ormai adulto. Al tempo, in realtà, un Elkanà c’è stato: ben presto evaporato dopo aver disconosciuto il figlio nato con un ritardo cognitivo. Oggi Joël è un trentenne con un impiego in una struttura di lavoro protetta per persone vulnerabili, innamorato e presto padre. Fin qui tutto bene; in realtà non proprio perché sappiamo quanto il binomio sessualità e disabilità, e ancor prima corporeità e disabilità, nella mentalità comune sia ancora un sentiero spesso interdetto, dimenticando tristemente che non si tratta di figure angeliche asessuate, ma di persone con pulsioni, attrazioni e desideri.
In questa fusione estrema è in pausa anche la sessualità di Mona e la sua corporeità è ancora stretta ad un cordone ombelicale appeso alla sua anima: è questa la prospettiva nitida e problematica che emerge proprio nell’incipit del film tra madre e figlio in piscina, un ambiente uterino tout-court, dove i dialoghi e la giocosità sembrano far pensare ad un legame ancora troppo orientato alle dinamiche dell’infanzia. Ancora una volta viene in mente Anna che dice ad Elkanà riferendosi al tempio di Silo: “Non verrò, finché il bambino non sia svezzato e io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per sempre” (1Sam 1,22). E se Anna, tenendo fede al suo impegno, davvero porta Samuele al tempio quando “era ancora un fanciullo” (1Sam 1,24), Mona invece sembra incagliata in questo svezzamento mai concluso e la prova ne è la sua routine totalmente impostata attorno ai bisogni del figlio, senza mai immaginarlo in una sua autonomia ma che nel frattempo lui sta già orchestrando. Joël ha, infatti, in serbo per la madre una doccia fredda che si chiama Océane, un nome che è già un destino pronto a prosciugare la piscina corpo a corpo. Océane, anche lei con una disabilità intellettiva, lavora con Joël ed è assolutamente a suo agio nel vivere con lui effusioni e momenti di intimità. La giovane affronta i suoi genitori senza paura di rivendicare un futuro di coppia e di famiglia totalmente emancipato. Tutti sono invitati a tagliare il traguardo anche nei colloqui con la terapeuta e i genitori anche a farsene una ragione. Sono passaggi tosti e vanno ascoltate seriamente le rimostranze di tutti. Ognuno ha le ragioni dell’amore che finora l’ha sorretto fino a là.
Va detto che Anne-Sophie Bailly, qui regista e sceneggiatrice, riesce a intrecciare in modo magistrale tutte le implicanze che la situazione porta in dote: i diritti delle persone con disabilità in ambito di sessualità e procreazione, l’attenzione al consenso, il tema della salute del nascituro a livello genetico, la responsabilità di cura che richiede la genitorialità. Nel suo discorso filmico nulla viene relegato a imprudente banalità o a dolciastra retorica, candidando così l’opera a partecipare in maniera davvero autorevole al dibattito contemporaneo sull’inclusività, talvolta appiattito su proclami che non mettono davvero al centro chi vive queste sfide nel proprio quotidiano di figlio o genitore. Il ventaglio di emozioni che travolgono la madre a causa della rincorsa all’emancipazione da parte del figlio è reso tangibile dalla fisicità e della prossemica di Laure Calamy, oltremodo credibile come già era accaduto anche in Full time (2021) dove vestiva i panni di Julie, un’altra madre single lavoratrice. Il resto del “miracolo” – ed effettivamente oggi quanti registi lavorano così? – è aver coinvolto Charles Peccia Galletto e Julie Froger, realmente alle prese con la disabilità nella vita, per interpretare Joël e Océane, ancorando così il set ad un modello di lavoro squisitamente inclusivo, proprio perché attento alle loro specificità e bisogni e dotato di figure professionali pronti a sostenerli in questa esperienza filmica. Froger è stata scovata in un laboratorio di improvvisazione in una struttura protetta e Peccia Galletto è un attore professionista con un proprio agente specializzato in questo ambito (a proposito del diritto ad un progetto di vita per tutti).
Bailly mette a fuoco nella prima parte del film le contraddizioni che appartengono legittimamente a tantissime famiglie – verrebbe da aggiungere anche a tutte quelle dove la disabilità non è presente – dove l’eccesso di amore e di cura da una benedizione può trasformarsi quasi in una maledizione che limita la crescita della persona e tirando giù tutti in un baratro, come ricorderà Joël alla madre in uno dei momenti più laceranti di Tutto l’amore che serve. Non si può essere dei pappagallini imprigionati insieme in eterno – toccante il titolo originale francese Tutto l’amore che serve – e come ricorderà in ospedale l’infermiera, in occasione della morte della madre di Mona, i ruoli sono destinati ad invertirsi dentro la logica del limite della vita. Chi si occuperà di lei? Il palco inizia decisamente a scricchiolare e questa madre deve ritrovare la donna: è la strada di casa, è la via del sé. La seconda parte del film la regia allarga, allora, il suo sguardo sui protagonisti che iniziano a comparire in campi larghi, in particolare il figlio, in una necessaria e profetica solitudine.
L’erotismo concesso al figlio apre in una rinnovata simbiosi le porte alla possibilità di una vita affettiva anche alla madre: si annoti che non vi è niente di romantico, il disordine è eccellente, il corpo torna a vivere tra liberazioni ed imbarazzi, smarrimenti dei sensi e sfoghi isterici. Come “Volevo un figlio normale”: lasciar andare il figlio (al tempio?) significa per Mona anche poter finalmente urlare questa frase, dopo più di trent’anni, all’uomo che inizia a frequentare. Di fronte al disorientamento di quest’uomo vorremmo poter dire di Mona quello che Anna rispose al sacerdote Eli: “No, mio signore; io sono una donna affranta e non ho bevuto né vino né altra bevanda inebriante, ma sto solo sfogando il mio cuore davanti al Signore. Non considerare la tua schiava una donna perversa, poiché finora mi ha fatto parlare l’eccesso del mio dolore e della mia angoscia” (1Sam 1,15-16). Difficile congedarsi da questo film attraversato dall’umanità esondante di una regista di appena 34 anni. Possiamo staccarci, però, nutriti dalla spinta incontenibile che solo la folle speranza insita in ogni taglio del cordone può concedere e affidare al tempio il meglio che abbiamo potuto fare con tutte le ambiguità del lavoro di una vita. E con Anna dire anche noi “Anch’io lascio che il Signore lo richieda” (1Sam 1,28).
- Leggi anche: Dopo i titoli di coda: UN BIGLIETTO PER LA NORVEGIA!